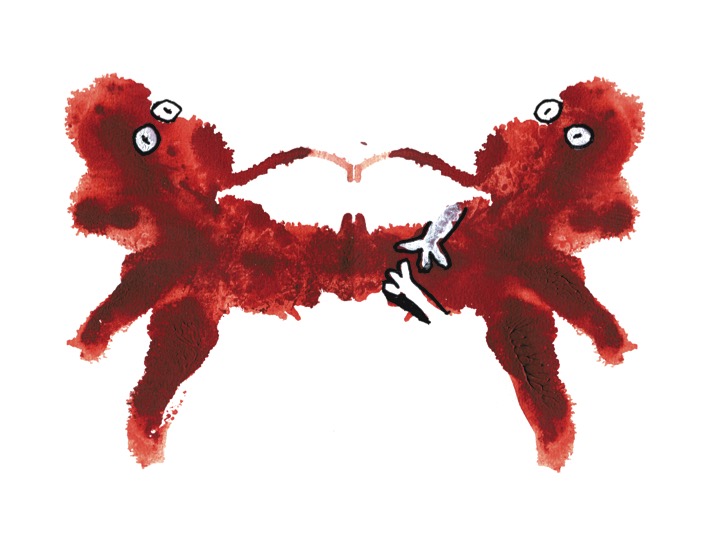La conversazione che segue è stata pubblicata in italiano nel mio quarto libro A passo leggero, che esplora l’empatia come motore di cambiamento positivo. Il professor Rizzolatti e il suo team dell’Università di Parma hanno scoperto il meccanismo specchio nel 1995.
—-
I neuroni specchio sono cellule cerebrali che si attivano sia quando si compie un’azione (mangio un cioccolatino) sia quando la si osserva compiuta da un altro (ti guardo mentre mangi un cioccolatino). Non solo: rispondono all’obiettivo di tale azione e all’intenzione, che si riflette a livello motorio (mentre ti guardo prendere il cioccolatino mi si attivano i muscoli della bocca prima che tu la apra). I neuroni specchio fanno sì che io senta ciò che sente l’altro. L’esperimento, reso possibile grazie alla scoperta della risonanza magnetica che ci permette di misurare in tempo reale l’afflusso del sangue alle varie aree del cervello, parte dalle scimmie e riesce a dimostrare che negli umani viene rispecchiata perfino la qualità dell’azione che si osserva. Il nostro cervello, in sostanza, produce una sorta di simulazione virtuale dell’azione altrui, e questo offre una nuova comprensione sul principio di emulazione che è alla base dell’apprendimento.
Professore, la sua scoperta sembra avere rivoluzionato il campo delle neuroscienze, e non solo…
Forse è capitata in un momento in cui si avvertiva il bisogno di un cambiamento, dando una base scientifica a qualcosa che la gente sentiva.
Come nasce il nome “neuroni specchio”?
Sa che non lo so? è una di quelle cose misteriose… Credo che l’abbiamo usato a un certo punto in laboratorio. Non so com’è venuto fuori, onestamente. È nato da solo. (ride) Non abbiamo pensato, come potrebbe fare un giornalista, a un marchio di successo. Comunque è stata una fortuna perché è piaciuto molto. È come chiamare una macchina Panda… Funziona.
Credevo che si riferisse allo stadio dello specchio teorizzato da Lacan, la fase in cui il bambino osservandosi nello specchio capisce di essere “io”…
No, non ci avevamo pensato.
Intorno alla sua scoperta, l’economista Jeremy Rifkin ha costruito la teoria dell’Empathic Society, e il neuroscienziato Vilayanur Ramachandran ha scritto che i neuroni specchio saranno per la psicologia quello che il DNA è stato per la biologia.
Rifkin ama i nostri dati, ma non l’ho mai incontrato. Ramachandran è un personaggio unico, uno scienziato creativo, comunicatore come nessun altro!sentirlo parlare, guardi… è magico! nei congressi abbiamo talvolta sessioni di dieci minuti in cui molti si rifiutano di parlare dicendo che sono troppo corte, mentre lui in quei dieci minuti riesce a fare uno show, e nello stesso tempo sviscera l’argomento mettendo insieme i metodi, i risultati e le idee. Da non credere.
Lui è empatico?
Terribilmente empatico! E pensi che quando ha cominciato a scrivere del nostro gruppo non ci eravamo ancora conosciuti… è una grossa generosità da parte di uno scienziato valorizzare così il lavoro di un altro.
Secondo Ramachandran sono stati proprio i neuroni specchio a favorire il cosiddetto “Big Bang” culturale avvenuto circa 50/100.000 anni fa, quando in un tempo relativamente breve l’homo sapiens inventa il fuoco e il linguaggio e comincia a servirsi degli utensili.
Questa è la sua grande idea, sì. E penso che ci sia molto di vero – oddio, in una cosa come questa non si può parlare di vero o falso – comunque concordo sul fatto che l’uomo diventa animale culturale nel momento in cui impara a imitare i suoi simili. Quando sappiamo imitare gli altri, riusciamo innanzitutto a far sì che se tu hai inventato qualcosa i tuoi figli possono continuare a farlo, i tuoi vicini lo adottano, e quindi l’invenzione si consolida.
Inoltre, come è stato sottolineato da alcuni psicologi, l’imitazione è un meccanismo di identificazione, quindi rafforza il legame sociale nella tribù, che diventa più coesa. Perciò c’è un vantaggio tecnologico e un vantaggio sociale e psicologico. Insomma, l’imitazione è un… come dire… un “trucchetto” geniale che la natura ha escogitato per renderci come siamo, diversi da tutti gli altri animali.
E anche per accelerare l’evoluzione…
Non c’è dubbio. Pensi alla lentezza della civiltà egiziana: per duemila anni hanno fatto più o meno le stesse cose; poi con i greci e i romani si è avuta un’accelerazione fino a quella attuale, paurosa.
Vede, nel momento in cui l’imitazione fa sì che in qualche maniera io e te ci sentiamo eguali e ci capiamo – questo è stato ben studiato nello sviluppo del bambino – allora anche la tua morte è la morte mia, costruisco una tomba perché non posso sopportare che tu sparisca, compare la religione, il bisogno di farti rimanere… mentre se invece tu sei una bestia come un’altra, pazienza.
È uno dei grandi misteri: perché improvvisamente succede tutto insieme? cominciamo a disegnare, a celebrare i riti, nascono le religioni… se è vero che a un certo punto la comunità acquista un nuovo significato é come diceva Martin Buber“tue iodiventano la stessa cosa”, allora si capisce perché ho bisogno della religione per assicurarti la sopravvivenza, perché così ti rivedrò nell’ altro mondo.
Quindi il nucleo è l’empatia, il rapporto empatico, che crea affetto, che crea appartenenza, che crea condivisione…
Più che altro appartenenza: credo che anche gli animali abbiano un certo grado di empatia. Però la chiave è l’appartenenza, il tu eio. Chiaro che se uno della tribù sta male, soffrono tutti.
Però se sei empatico senti una nausea tremenda…
Senti una nausea tremenda, sicuramente. Ma quello che conta è il rispecchiarsi nell’altro. Siamo la stessa cosa.
Si rompono i confini.
Si rompono i confini, sì. Cioè, si sono già rotti prima, con i neuroni specchio, ma in maniera molto limitata. Infatti se io capisco la tua azione, la tua intenzione, magari cerco di imbrogliarti… per questo gli etologi di Saint Andrews, con Byrne e Whiten , parlano di “intelligenza machiavellica”. Quello c’era già negli scimpanzé, nei gorilla, ma dopo diventa qualcosa di più, perché con l’imitazione c’è una partecipazione: quello che faccio io lo fai anche tu, quindi c’è qualcosa che ci unisce. Perché nasce la religione? Alcuni evoluzionisti ti dicono: è il linguaggio. Va be’, ma anche se comunichi meglio, che bisogno hai della religione? Invece, se tu e io siamo la stessa cosa, quindi legati, la tua perdita diventa un colpo terribile… E allora la tribù, il gruppo, vuole creare un tempio, avere un luogo in cui questi morti ritornano. Secondo me è molto bello, questo.” Per chi suona la campana? suona anche per te.”
In quante aree del cervello si trovano i neuroni specchio?
Beh, più che di neuroni specchio, bisognerebbe parlare di un meccanismo specchio, grazie al quale certi neuroni trasformano quello che io vedo in un programma motorio mio, così la percezione del mondo esterno diventa conoscenza mia personale. Qui sta la differenza tra la capacità di capire mediante neuroni specchio e la capacità di capire mediante la logica, che è un procedimento astratto. Quanto al meccanismo specchio, sappiamo che è presente nelle aree emozionali, l’insula e il giro del cingolo, e poi nei circuiti parieto-frontali che sono legati alla comprensione delle azioni altrui. I primi esperimenti che abbiamo fatto riguardavano l’atto di afferrare. Un ricercatore belga, Guy Orban, ha recentemente trovato una zona corticale che risponde quando vedo uno che si arrampica, una regione specchio più dorsale dove sono rappresentati le gambe e il corpo…
Questo meccanismo specchio è presente in tutti? fin dalla nascita?
Direi di sì, tutti abbiamo i neuroni specchio, a meno che non ci sia una patologia grave.
E cosa può inibire il loro sviluppo, la loro manifestazione?
La società. In realtà noi tutti siamo determinati dalla nostra natura biologica e dalla cultura. Quindi tutto il nostro comportamento ha due radici, che si uniscono e formano una personalità. Poi se la società è organizzata bene, le cose positive legate alla nostra natura biologica si sviluppano, se è organizzata male non si sviluppano, anzi vengono tarpate.
Per risvegliare i neuroni specchio è meglio che ci sia il contatto fisico tra le persone?
Senz’altro. Anche i filmati funzionano, ma sono molto meno efficaci: i neuroni si attivano molto di più se tu fai un’azione davanti alla scimmia o un uomo – d’altra parte per noi sperimentatori i filmati sono molto più facili da usare: li acceleri, li rallenti, li manipoli, fai anche cose che non esistono in natura…
C’è un particolare tipo di gesti che tende ad attivarli maggiormente?
Soprattutto quelli di violenza, purtroppo. Esaminando il film Il brutto, il buono e il cattivo un gruppo di ricercatori israeliani ha trovato che il cervello si attiva maggiormente quando vede la pistola che spara, e cose del genere. Anche noi abbiamo fatto una ricerca partendo da due spot pubblicitari: nel primo c’è un ragazzo che mangia un cracker, arriva una bella ragazza procace (quindi c’è anche questo elemento d’interesse) che gli fa un sorriso, poi a un tratto gli porta via il cracker e scappa. Nel secondo filmato ci sono gli stessi personaggi, ma qui la ragazza chiede gentilmente il cracker. Be’, l’attivazione corticale è molto più forte quando si verifica quella specie di microviolenza, che poi chiaramente è scherzosa… eppure il cervello si attiva molto di più.
Quale parte del cervello si attiva?
Le aree emozionali, ovviamente. Se dopo il messaggio tu fai vedere il cracker, l’impatto è molto maggiore perché tutto il cervello si è risvegliato in seguito a questa piccola violenza… I pubblicitari quando pianificano i loro spot intuiscono qual è il meccanismo più efficace, non so come facciano a saperlo ma lo sanno, altrimenti perché la ragazza dovrebbe rubare il cracker invece di chiederlo sorridendo?
E i neuroni specchio come si comportano davanti a questo piccolo gesto invasivo?
Lo vedono, lo rispecchiano, poi attivano le aree emozionali, è un processo di amplificazione.
E ciò che segue viene ricordato meglio.
Sì.
E se al posto dello stimolo invasivo c’è una chiave di humour? Ho sentito dire che se fai ridere qualcuno, l’informazione che segue viene recepita meglio.
Ci deve essere un elemento sorpresa, credo. Però con la gentilezza non funziona molto, forse perché non c’è sorpresa, non so…
Anche se oggi come oggi sorprende più la gentilezza…
E’ vero! soprattutto tra gli adolescenti forse la gentilezza avrebbe colpito di più.
(Ridiamo insieme.) Non è che sui sentimenti positivi si sa meno?
Be’, sì. Attualmente si sa molto sul dolore o sul disgusto, si sa molto poco invece sui sentimenti positivi… è molto più facile lavorare sui negativi.
Secondo lei perché?
Be’, gli psicologi evolutivi dicono che il negativo è molto più importante. Se vedo un tizio con la faccia disgustata significa che il cibo che mangia potrebbe farmi male, se vedo un’espressione di dolore vuol dire che c’è qualcosa di potenzialmente dannoso per me e devo stare attento. Invece se vedo due innamorati… vabbè, buon per loro, ma resto indifferente. Magari se sono buono provo piacere per loro, se sono un invidioso penso fortunato lui… Ma in genere dal punto di vista evolutivo le persone felici lasciano indifferenti, le persone che hanno problemi potrebbero creare problemi anche a me.
Quindi è possibile sfruttare l’empatia in modo anche strumentale…
Be’, la propaganda lo fa spesso, no? Pensi alle foche! la fochina giovane è un animale simpaticissimo e tenerissimo, che si presta come nessun altro alla propaganda in favore degli animali… Il povero ratto viene derattificato in continuazione, ne vengono ammazzati a milioni, ma non vediamo mai dei topi che vengono uccisi perché non susciterebbero empatia, mentre venti foche fanno una pena incredibile perché sembrano dei bambini, e quindi uccidere una foca giovane diventa un delitto. Gli americani non permettono ai reporter di andare nelle regioni in guerra perché hanno paura che circolino le fotografie… La crudeltà della guerra diventa molto più crudele se tu la fotografi. In parole fa meno effetto, un conto è sentirsi dire che hanno ammazzato tre persone, un conto è vederle…
Casi di propaganda al negativo ne conosciamo tanti…
Pensi a Hitler! Ha portato una popolazione di persone “per bene”, colte, con una grande tradizione artistica e scientifica, a diventare dei mostri o comunque a non vedere quello che succedeva. Attraverso la propaganda è riuscito a disattivare l’empatia di un popolo intero…
Quando si pensa ai pogrom o ai campi di concentramento nazisti si fa fatica a credere che l’empatia sia un fattore biologico connaturato agli esseri umani…
Be’, ma proprio tramite la propaganda Hitler riuscì a convincere un’intera nazione che gli ebrei non erano esseri umani. Ha battuto e ribattuto sulle differenze, inculcando nelle menti l’idea che le differenze dimostravano che erano esseri inferiori, e qui la propaganda è riuscita ad azzerare il fattore biologico… Secondo alcuni la grande fortuna di Hitler fu anche quella di poter disporre di un mezzo di comunicazione appena inventato e cioè la radio, che permetteva di raggiungere milioni di persone e risultava ancora più autorevole proprio per la sua novità: “L’ha detto la radio!”.
Che rapporto c’è tra potere ed empatia?
Guardi, io penso che l’uomo di potere sfrutti una specie di empatia generalizzata. Qualcuno ha detto che i grandi rivoluzionari amano l’umanità e non l’uomo. È proprio vero, perché se tu ami l’umanità e non ami quelli intorno a te, quando qualcuno ostacola questo tuo grande sogno di umanità lo maltratti o lo fai fuori. Si legge anche in Dostoevskij no? nei Demoni…c’è questa degenerazione dell’idealismo, questa contraddizione tra ‘io amo l’umanità’ e ‘sono un superuomo quindi ammazzo queste persone per il bene dell’umanità’. L’empatia viene in qualche modo eliminata per un fine “superiore”. E si trasforma nel suo opposto.
Ma secondo lei il sogno di una società empatica è possibile?
Di più: è necessario. La nostra società ha bisogno di empatia come nessuna prima. Innanzitutto perché con la tecnologia è aumentata la possibilità di nuocere al prossimo – una persona sola può distruggere un aeroporto, un aeroplano può andare contro un grattacielo, se lei ci pensa è quasi un miracolo che il terrorismo sia tutto sommato sotto controllo e non ci siano matti che fanno cose terribili. Più una società diventa complessa più ci deve essere empatia, se no la possibilità di distruggerla è infinita.
Oggigiorno anche l’indice di felicità sembra essere ai minimi storici…
Verissimo. Amici psicanalisti mi raccontano di industriali di successo che vanno da loro perché si sentono profondamente infelici, dicono: non mi apprezzano come merito, io sono molto più bravo di così, ho una grande insoddisfazione dentro… ed è gente che ha successo, che ha soldi! Eppure vanno dallo psicanalista a farsi consolare..
A maggior ragione dovrebbe essere considerato utile indagare meglio le dinamiche della felicità.
Sarebbe molto interessante, ma sarebbe più compito dei sociologi che dei scienziati no? Noi possiamo dare una base scientifica, ma non sostituirci a loro.
Perché no?
Perché l’infelicità diffusa è un problema sociale, e tradizionalmente i problemi sociali sono trattati dai sociologi, o eventualmente dagli psicologi o dagli psicanalisti… fino a pochissimo tempo fa il neurofisiologo non si interessava dei rapporti tra l’io e il tu, si interessava solo alla persona singola.
Però, professore, la sua scoperta ha rotto gli argini e le barriere, ha avuto le reazioni più incredibili da ambiti totalmente diversi…
È vero, è vero…
Non è forse un segnale che è ora di romperle, queste barriere tra i saperi?
Sì, è così, la risposta è sì. E sta avvenendo, anche sul piano sperimentale: per esempio si cominciano a fare risonanze magnetiche con due persone, è una cosa buffissima, i due entrano insieme come in un lettone, e così riesci a leggere simultaneamente i due cervelli mentre interagiscono. La tendenza è di non studiare più l’individuo come singolo, come elaboratore di informazione, ma come essere sociale, per vedere cosa succede nei rapporti tra due – più di due attualmente è impossibile, la tecnologia non lo permette.
Ci sono esperimenti che suggeriscono tra l’osservatore e l’osservato correlazioni di tipo diverso da quelle accertate finora?
Be’ deve sapere che noi abbiamo dei neuroni che rispondono sia quando vengo toccato direttamente, sia quando viene sfiorato il mio spazio peri-personale. Per esempio, lo stesso neurone si attiva sia se lei mi tocca il naso sia se avvicina il dito al mio naso. Intorno a noi c’è come un cuscino di aria diciamo, e infatti ci infastidiamo se qualcuno si avvicina troppo, lo sentiamo come un’intrusione nel nostro spazio. Ebbene, c’è un ricercatore giapponese… che adesso è da noi tra parentesi, si chiama Hiroaki Ishida, il quale ha scoperto che se mentre la scimmia mi sta guardando qualcuno invade lo spazio intorno al mio corpo, in lei si attiva lo stesso neurone di quando si invade lo spazio intorno al suo. È un meccanismo specchio molto interessante perché è legato alla corporeità: non solo mi “approprio” della tua azione, ma il tuo corpo diventa il mio. Non solo la tua azione diventa la mia azione ma il tuo corpo e il mio corpo sono simili.Tutto sembra convergere verso l’evidenza che noi siamo molto più uniti l’uno all’altro di quanto crediamo… è la società che poi tende in ogni modo a distruggere questo vincolo biologico: la nostra società.
A livello di società, secondo lei quali sono i fattori che anche storicamente hanno disattivato il meccanismo empatico nell’individuo?
Penso che una trasformazione profonda sia cominciata a partire dalla rivoluzione di Berkeley… chiaramente questa è una mia opinione personale, non parlo da scienziato, ma il movimento studentesco ha avviato un cambiamento radicale – beninteso, la motivazione primaria era giusta, c’era una reazione a un modello tradizionale, le donne volevano essere libere, ma la libertà deve essere legata a un rapporto sociale. Se per libertà s’intende “esisto solo io”, guai. O meglio, va bene quando sei adolescente e ti stai affrancando dai genitori, ma quando hai superato i trenta, se non hai un compagno, se non hai una famiglia, se non coltivi degli obiettivi sociali, un qualcosa in cui credere, la capacità di riconoscersi nell’altro viene meno. Poi i maschi sono venuti dietro, ma credo che fosse essenzialmente una rivoluzione femminile. In qualche modo la libertà e la spensieratezza del “college” sono diventate un modello di vita… io non ho fatto il “college” negli USA, ma basta vedere i film dell’epoca per avere il senso di una vita molto libera e anche piena di stimoli intellettuali ma senza responsabilità tranne quella di preparare gli esami… però poi cresci, ti sposi, fai i figli, e quella vita lì è difficile da fare….
Quindi c’è stato un vuoto di valori?
Più che un vuoto direi una sopravvalutazione dell’io. La mia generazione quando si sposava aveva l’idea di creare qualcosa di stabile e definitivo. In un certo modo la moglie entrava a far parte della famiglia, anche se le famiglie non erano già più numerose come prima… Adesso sposarsi è diventato una specie di contratto a termine.
È anche un effetto della crisi della religione, forse…
Mah… già quando io ero giovane l’aspetto religioso contava molto poco. Soprattutto nell’ambiente intellettuale. L’idea era di fondare una piccola società, qualcosa che durasse, e in genere si sperava di avere figli. Non è che si andava insieme perché ci piaceva solo andare a letto. Era un miniprogetto che si innestava in quei progetti comuni in cui allora credevamo molto.
Questa rivoluzione avviata negli anni ’60 sotto il segno dell’individualismo contestatore poi negli anni ’80 si è trasformata in un individualismo di tipo diciamo di destra – fregatene di tutto, l’unica cosa che conta è diventare ricco… però adesso a me pare che ci sia un riflusso verso l’idea che tutto sommato abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Quando parlo in pubblico, sento l’entusiasmo di gente che dice: ma allora non siamo proprio così cattivi, così egoisti… cioè c’è questa necessità di credere nell’aiuto reciproco, ed è una cosa che trovo non solo negli scienziati ma anche nella gente diciamo più semplice… non solo nell’anziano che magari si sente abbandonato ed è tutto contento che uno parli di queste cose, ma anche in tanti ragazzi giovani.
Lei parlava prima delle famiglie numerose: forse il bisogno odierno di empatia sociale è anche legato al progressivo restringersi delle famiglie, all’affermarsi delle cosiddette famiglie “atomiche”, composte da una o due persone…
Effettivamente la vecchia famiglia creava anche una specie di ombrello di protezione per i vecchi, c’era la zia, c’era la nonna, ma era anche un paracadute sociale, lo zio rimasto magari senza lavoro che però viveva insieme… Ancora nella mia infanzia praticamente ogni domenica i miei genitori alle cinque andavano a trovare i nonni e si prendeva il tè tutti insieme. Ricordo che tornavo dalla partita di calcio e bisognava andare dai nonni. E si era già molto dopo la guerra… adesso, non so, i miei nipoti quando vengono a trovarmi è solo perché hanno bisogno di qualcosa o magari per giocare ma non è che vengono puntualmente alle cinque… non c’è più quel legame…
Erano riti importanti…
I riti sono spariti completamente, no? Eppure servivano a stare uniti. Se tu sai che ogni domenica alle 5 si va a trovare i nonni, diventa un’abitudine come il Natale o come altri riti che si sono conservati, se invece lasci tutto libero, alla fine non ci vai perché una volta hai da fare, la volta dopo hai il mal di testa…
Quanti figli ha lei?
Due, un maschio e una femmina. Entrambi con figli.
I collanti sociali cambiano… Oggi c’è il social network.
È un bene o un male?
Lei che ne dice?
Mah… io ho paura che sia più un male che un bene, a me pare che il rapporto corporeo, il rapporto vis-à-vis, il contatto fisico crei un legame molto più vero di quello che hai con qualcuno con cui chiacchieri. Cioè, non vorrei che questo finisse per portarci a un isolamento…
A chi lo dice. Quando si hanno dei figli adolescenti come ne ho io è difficile non farci caso…
Per esempio adesso il mio nipote più grande ha quattordici anni e a volte mi sembra quasi di averlo perduto, perché quando aveva cinque o sei anni gli piaceva stare assieme a me, giocavamo ai soldatini, mi cercava… adesso che va al ginnasio viene da noi a pranzo perché mia figlia abita fuori città, ma appena ha finito di mangiare si alza e va in camera sua e si mette al computer, con Skype e così via… certo avrà anche i suoi amici, talvolta escono la sera, ma il grosso del tempo lo passa con… il computer.
Ma collettivamente secondo lei l’empatia è aumentata o diminuita?
È un discorso molto complesso. Ho partecipato di recente a un convegno sull’empatia che si è tenuto a Heidelberg e un amico ceco mi faceva notare come è cambiato il concetto di empatia. Cioè, attualmente è molto più sociale. Se muore un soldato nostro in Afganistan è un dramma nazionale, mentre durante la prima guerra mondiale i generali non avevano nessuna empatia per i soldati, li mandavano a morire perché non li consideravano come se stessi, credo ci fosse l’idea aristocratica che il nobile, l’ufficiale, fosse un uomo di tipo diverso. Il concetto attuale che tutti debbano avere diritto alla salute è un’empatia inconcepibile cent’anni fa. Un tempo c’era la carità, i buoni davano dei soldi. Adesso l’empatia sociale è diventata quasi obbligatoria…
Sa cosa, forse è anche diventato tutto più istituzionalizzato. Cioè in qualche maniera ci preoccupiamo meno dell’altro perché pensiamo: c’è il Servizio Sanitario Nazionale, ci sono i pompieri… non c’è più quell’aiuto diretto che c’era in passato, quando mancava l’intervento dello Stato… questo in fondo ci rendeva più empatici.
Ah, questa è una chiave interessante…
Abbiamo un po’ delegato l’empatia al servizio pubblico: lo Stato deve occuparsi della sanità, della scuola, della sicurezza e del benessere dei cittadini: ne risulta una forma di deresponsabilizzazione… io penso solo a me stesso e delego le istituzioni, salvo poi arrabbiarmi se il servizio non è all’altezza delle mie aspettative.
Un altro fattore, forse più in Italia che altrove, potrebbe essere il crollo del partito comunista. Per molti giovani era un momento di aggregazione, un partecipare insieme a un’idea di società migliore, andavano a vendere l’Unità la mattina, c’erano le cellule, c’erano le sezioni… Adesso è diventato come un partito americano, è finita l’aggregazione….
E sul piano del lavoro?
Be’, ci sono mestieri in cui l’empatia deve essere ridotta quasi per necessità. Cosa vuole, le forze speciali hanno un training per essere poco empatici, se no come fanno a intervenire. Non che diventino delle bestie, ma nel momento in cui impugnano il manganello e ricevono l’ordine, non possono commuoversi se vedono del sangue o una ragazza che piange. A volte siamo socialmente tenuti a diminuire l’empatia. Però la cosa dovrebbe limitarsi a questi corpi speciali, non riguardare il cittadino normale.
Ogni volta che sono in un aeroporto mi meraviglio al pensiero di tutte quelle persone che si mettono in fila, si lasciano guidare, rispettano gli ordini… Quando ci fu l’eruzione di quel vulcano dal nome impronunciabile, ero di ritorno dalla Polonia e sono rimasto bloccato a Vienna. Si potrebbe pensare che in una situazione così drammatica la gente cerchi di fregarsi l’un l’altro e invece è scattata un’empatia veramente interessante… ci si aiutava, col telefonino, si cercava informazioni, ci si passava voce: c’è un treno che va a Innsbruck! prendiamolo, da lì riusciamo ad andare a Verona… il punto è che la società di oggi è talmente complessa che non può più permettersi l’individualismo.
Purtroppo non solo ci sentiamo separati dagli altri ma ci sentiamo separati anche dalla natura…
Lei trova che siamo separati dalla natura? Non mi sembra…
Be’, stiamo stravolgendo gli equilibri del pianeta con una certa dose d’indifferenza…
Può darsi, ma i borghesi continuano ad andare in montagna e ad amare la natura, nei romanzi dell’800 i poveri vivevano in città inquinate e sporche, mentre adesso, insomma, una gita fuori porta se la permettono…
Lei quindi non crede che amare la natura sia un istinto naturale?
Insomma… c’è un bel salto dall’amore per il prossimo all’amore per la natura…
Ma non dovremmo sentire la natura come qualcosa di affine?
Mah… evolutivamente lei pensa che si sia mai posto questo problema? No, la natura era un… datum, era lì. È solo la nostra generazione che ha incominciato a porsi il problema… credo che la preoccupazione per la natura sia più una costruzione intellettuale…
Ma senza le piante noi non respiriamo…
D’accordo, ma non facciamo questo ragionamento. Non è che pensiamo alla funzione clorofilliana…
Ma non dovremmo anche avere cognizione del loro ruolo, sentirle empaticamente come esseri viventi?
Ma qui i neuroni specchio non c’entrano!
Be’, allora sarebbe interessante verificare se si attivano i neuroni specchio quando vedo una quercia che viene abbattuta.
(Lungo silenzio)Beh, è abile lei, eh? mi tira fuori un argomento che… effettivamente sì, siccome anche la quercia è un essere vivente, quando viene abbattuta uno ci resta male, non c’è nessun dubbio, anche vedere un bambino che calpesta i fiori senza alcun motivo ci colpisce – allora, sì, empatizziamo, ma perché in quel momento consideriamo la quercia quasi come un essere vivente… cioè, è un essere vivente… ma gli diamo quasi una figura animalesca.
Solo questo?
Direi di sì, è un fenomeno quasi corporeo, perché la quercia è li, è un essere vivente e vederlo morire ci toglie… insomma, noi facciamo parte di… sì, in quel senso la natura è nostra. Però se devono costruire un’autostrada e per farla distruggono degli alberi, non si tratta più di empatia… uno deve valutare i pro e i contro, soppesare i vantaggi economici, non è più così immediato, è un processo logico che deve risolvere più un sociologo o un politico. Non è che io Giacomo Rizzolatti posso decidere se fanno bene a fare la Torino-Lione. Però con l’esempio dell’albero mi ha preso in contropiede, lo ammetto…
Torniamo alle possibili applicazioni, magari anche un po’ azzardate, dei neuroni specchio. Non pensa che la sua scoperta abbia in qualche modo convalidato il potere delle visualizzazioni?
In che senso?
Nelle tecniche di meditazione si insegna a visualizzare ciò che noi desideriamo avvenga; creandoci delle sequenze che attivano una risonanza interiore e fanno come da apripista al suo avverarsi…
Be’… il neuroscienziato francese Marc Jeannerod ha introdotto una distinzione tra motor imagerye visual imagery. La motor imagerysi ha quando penso a me stesso mentre faccio una cosa: qui ho dei risultati molto simili a quelli dei neuroni specchio, mi si attivano le stesse aree, mentre se semplicemente vedo o immagino una cosa statica l’efficacia è molto inferiore.
Questo collimerebbe con le tecniche di crescita personale attraverso la visualizzazione, che richiedono appunto di immaginare se stessi mentre si compie un’azione.
In effetti la motor imagery, immaginare di fare qualcosa, è estremamente potente, quasi potente come vedere. Anche se in quello che dice lei di scientifico non c’è moltissimo. C’è una ricercatrice tedesca, Tania Singer, adesso dirige il Max Planck Institute a Lipsia, lei ha fatto esperimenti sulla meditazione… però non mi pare che sia andata molto avanti…
Rientra nel suo dipartimento di studiare cosa accade quando uno esegue una visualizzazione motoria?
Sì, è stato fatto, in Francia. Proprio Jeannerod aveva pensato a una tecnica di riabilitazione per i colpiti da paralisi, dovevano immaginare di muoversi. I risultati c’erano, ma per i pazienti era faticoso. Noi facciamo qualcosa di simile, ma il nostro metodo prevede tre momenti: vedere, immaginare, fare. Cioè io vedo l’azione che non so fare, perché sono paralizzato, fatta da un altro, immagino di farla, e poi la eseguo nei limiti del possibile. E funziona abbastanza.
Conosce la storia dei D’Angelo? abitano a Milano tra l’altro… pochi giorni dopo la nascita del primogenito hanno scoperto che il bimbo aveva avuto un ictus prenatale all’emisfero destro del cervello.
Oh mamma, poverino…
Anche loro hanno in qualche modo applicato la sua scoperta…
Eh, ma… non è una cosa magica purtroppo…
Sì, ma sa cos’hanno fatto? hanno usato se stessi come modello per il bambino e i risultati sono stati sbalorditivi.
Ma sono stati bravissimi! È stata un’intuizione splendida quella di usare se stessi perché hanno la stessa maniera di muoversi, gli stessi geni… sarebbe stato molto meno efficace se avessero usato un estraneo come modello. Noi vorremmo fare qualcosa di simile in maniera tecnologica, coinvolgendo proprio i genitori e i parenti… ma questi D’Angelo meriterebbero davvero un premio…
A proposito, complimenti per il Brain Prize che ha da poco ricevuto a Copenaghen! Cos’ha significato per lei questo riconoscimento dedicato ai neuroscienziati che ogni anni si distinguono nel loro campo?
Sono stato contento sia per me sia per la scienza italiana, che nonostante le difficoltà rimane di alto valore. Poi la cifra è ingente.
Un milione di euro: un premio perfino più ricco del Nobel, che negli ultimi tempi è stato diminuito. Come lo spenderà?
Sarebbero tutti soldi miei, però non mi sembra giusto mettermeli in tasca. Pensavo di destinarne una parte a un fondo per la ricerca nel dipartimento di neuroscienze. La burocrazia è diventata insopportabile e l’unica soluzione per lavorare bene è avere risorse al di fuori dell’amministrazione universitaria.
Pensi che da noi c’e un canadese che voleva comperare un pezzo di plastica, gli occorreva per un esperimento. Costo, trenta euro. Ci hanno detto che dovevamo seguire la trafila stabilita dalla “spending review”. Attesa: un paio di settimane. Insomma, o paghiamo di tasca nostra o smettiamo di lavorare. Non le dico se uno ha bisogno di una prestazione professionale! Deve chiedere il permesso al rettore, che deve fare un annuncio a tutta l’università per vedere se qualcuno si presta gratuitamente, dopodiché, siccome ovviamente nessuno si presta, si istituisce il concorso, si aspettano venti giorni perché il bando diventi pubblico, si fa il concorso che, alla fine, va alla Corte dei conti per l’approvazione. Morale, se voglio un’analisi statistica devo aspettare tre mesi. In Germania ce l’hai in un giorno. Ci trattano come il catasto o il ministero dei Trasporti, dove forse è logico contenere al massimo i prezzi, ma per un pezzettino di plastica…
Per le spese ordinarie ci dovrebbe essere un responsabile di dipartimento che verifica che non si sperperi.
Certo, ma l’amministrazione universitaria non si fida. Nei paesi anglosassoni si va sulla fiducia – chiaro che se fai qualche cosa di male poi sei finito. Da noi tra spending review e legge Gelmini è praticamente impossibile lavorare. Il fondo che voglio creare servirà anche per queste piccole cose.
A proposito di riforma Gelmini, lei nel 2008 avanzò una proposta importante sul sistema universitario e sulla ricerca.
Sì, suggerivo di abolire le cattedre universitarie a vita, instaurando un sistema per cui ogni cinque anni una commissione ti esamina. Se sei bravo puoi restare anche fino a novant’anni, altrimenti vai a casa anche a cinquanta. Tengo molto a rilanciare questa proposta. Sei anni fa ricevetti molte lettere da giovani che dicevano: lei è un bell’egoista, ha avuto il posto a vita e adesso ci vuole controllare. Io credevo di favorirli, perché se mandi via tutta una serie di 50-60enni che non fanno niente poi hai più posto per i giovani. Il merito è un concetto basilare per l’università – forse per il catasto no, non credo ci sia una grande differenza tra un impiegato e l’altro, ma tra un professore universitario e un altro, sì.
È il sistema che vige al RIKEN, un centro di ricerca giapponese di altissimo livello, parallelo all’università. Lì non fanno complimenti, ti convocano e ti dicono: la sua produzione scientifica non è considerata buona, le diamo due anni per trovarsi un altro posto.
L’empatia non dovrebbe anche essere un ingrediente fondamentale nelle aule, tra professori e studenti?
Fondamentale. Ma questo tutti gli insegnanti lo sanno.
Sì ma quanti sono empatici nella sua esperienza? Diciamo la verità…
Beh… in effetti siamo tuttora ancorati all’idea che basti conoscere bene la propria materia per essere un buon insegnante. Ma è altrettanto importante saperla insegnare. Anche un medico non deve solo chiederti l’anamnesi, deve saperti fare le domande, entrare nel tuo io per capire la tua malattia. Idem per il magistrato… invece noi tendiamo ancora a considerare le due cose separate, e a sottovalutare la seconda. Invece i professori bravi a insegnare sono quelli che sanno dare entusiasmo ai ragazzi. Se non dai niente ai ragazzi, non imparano. Il rapporto empatico è fondamentale.
Quante forme di empatia avete finora classificato?
Be’ attualmente… dovendo proprio riassumere per sommi capi, direi che ci sono tre forme di empatia. Innanzitutto l’empatia emotiva, cioè l’empatia che ci fa “soffrire insieme”, “sentire insieme”, che è quella che ha reso popolare la scoperta dei neuroni specchio; poi c’è l’empatia diciamo cognitiva, la capacità di capire gli altri in base alle loro azioni, che prevede sia l’immedesimazione sia l’oggettivazione: ti capisco sia perché sei umano come me sia perché sei un oggetto che fa qualcosa; questa capacità varia a seconda del rapporto tra l’osservatore e l’osservato – per esempio, se sei la mia fidanzata probabilmente ti capisco meglio; e infine molto importanti per noi sono i cosiddetti vitality forms, una denominazione che si deve allo psicanalista Daniel Stern e riguarda la “qualità” dei gesti minimi. Se a tavola le chiedo di passarmi il sale, da come lo fa posso capire se è di buon umore, o distratta, o aggressiva. La qualità del gesto non l’avevamo mai studiata prima di Stern, e sia per noi sia per gli psicologi dell’infanzia il “come” è un fattore fondamentale, è l’inizio del rapporto sociale. Quando il bambino ancora non ha capacità logiche, capisce il HOW. Tra l’altro è proprio il tipo di empatia che sembra mancare agli autistici “high functioning”, quelli senza deficit cognitivi ma privi di un importante aggancio con la realtà…
Quindi è un meccanismo che prescinde completamente dal dato culturale… Sarebbe bello indagare meglio sulla qualità del gesto in un senso anche sociale, nella vita di tutti i giorni…
Certo, il gesto gentile è importante… sono convinto che un minimo di gentilezza col marito, coi bambini, appena vai al bar, cambierebbe già il mondo. Invece di “Caffè!” “Mi farebbe un caffè, per piacere?”
Cambiamo l’idea che il positivo è una palla!Si potrebbe sviluppare una ricerca imperniata sulla domanda “La gentilezza funziona?”…
Perché no? è un bellissimo titolo.