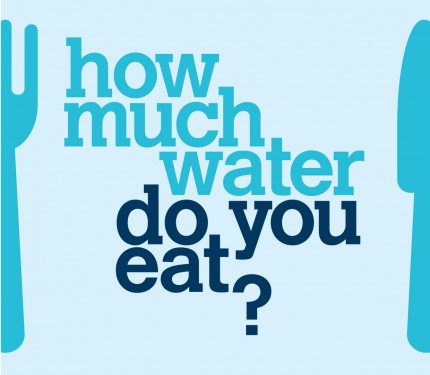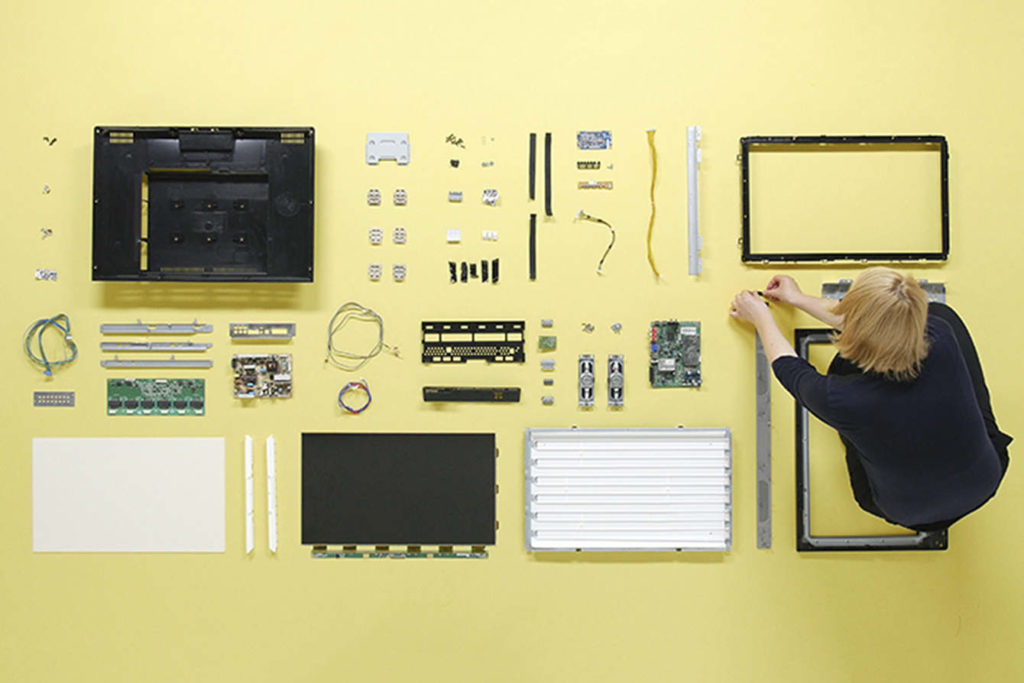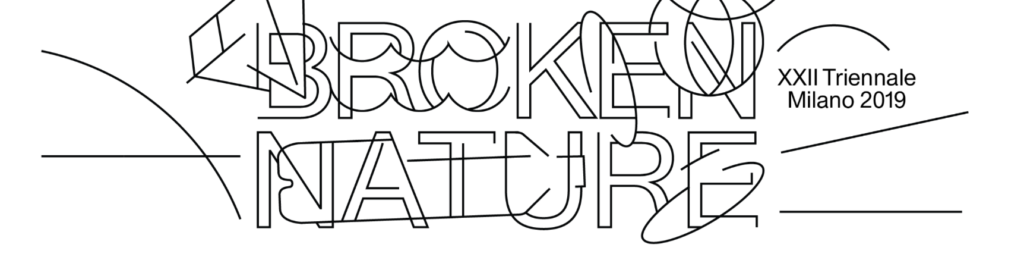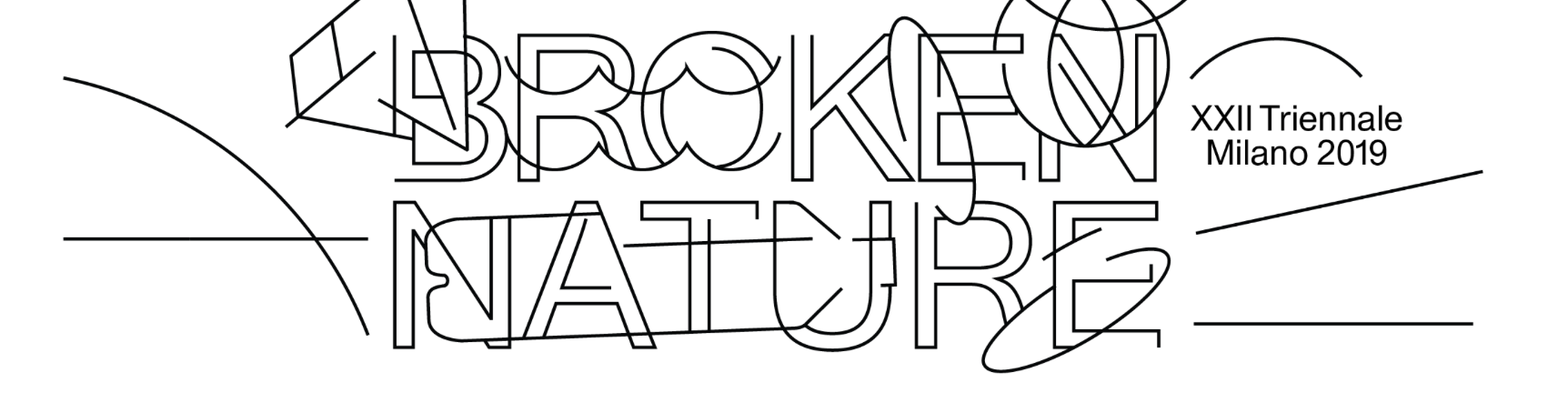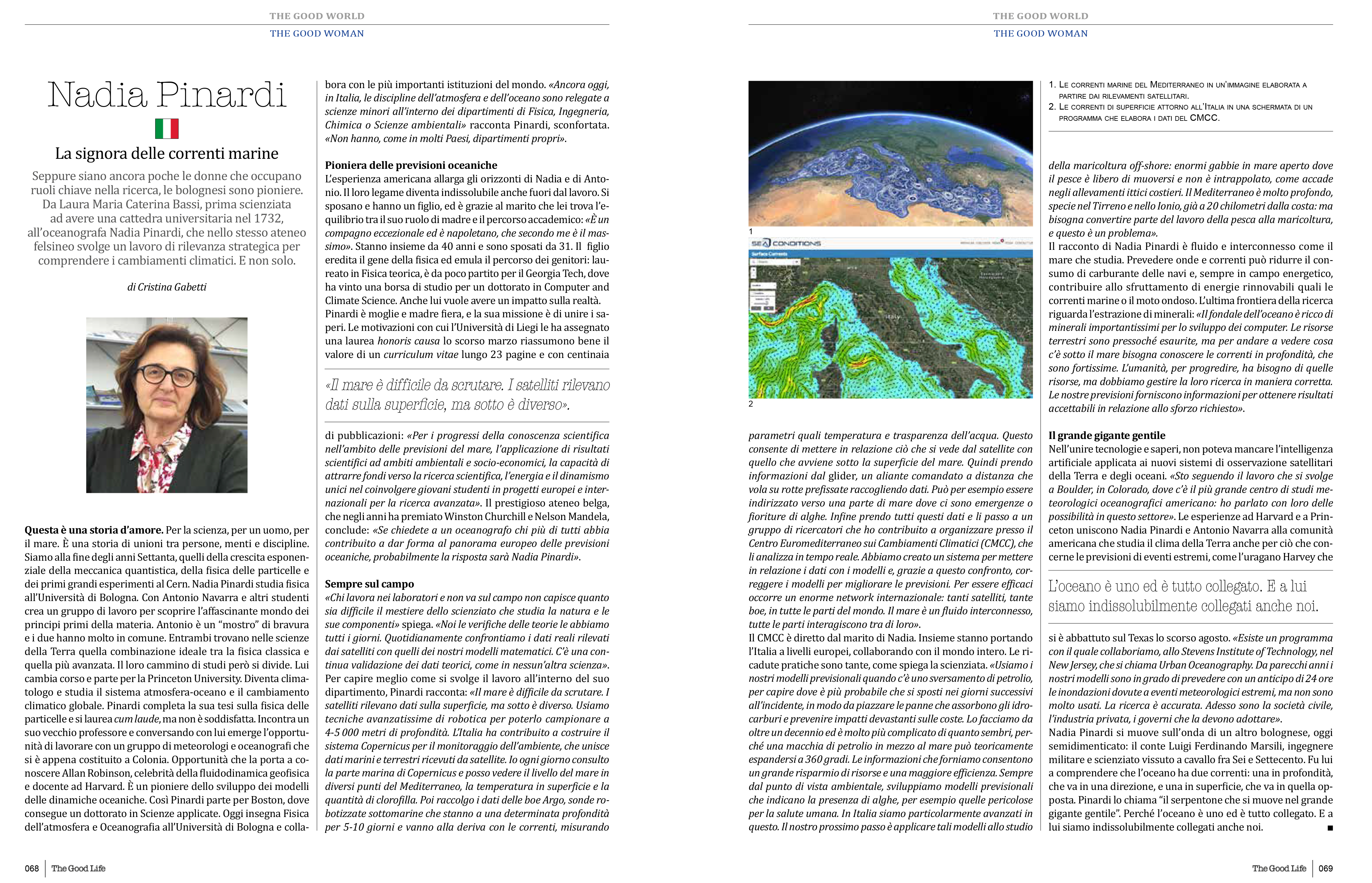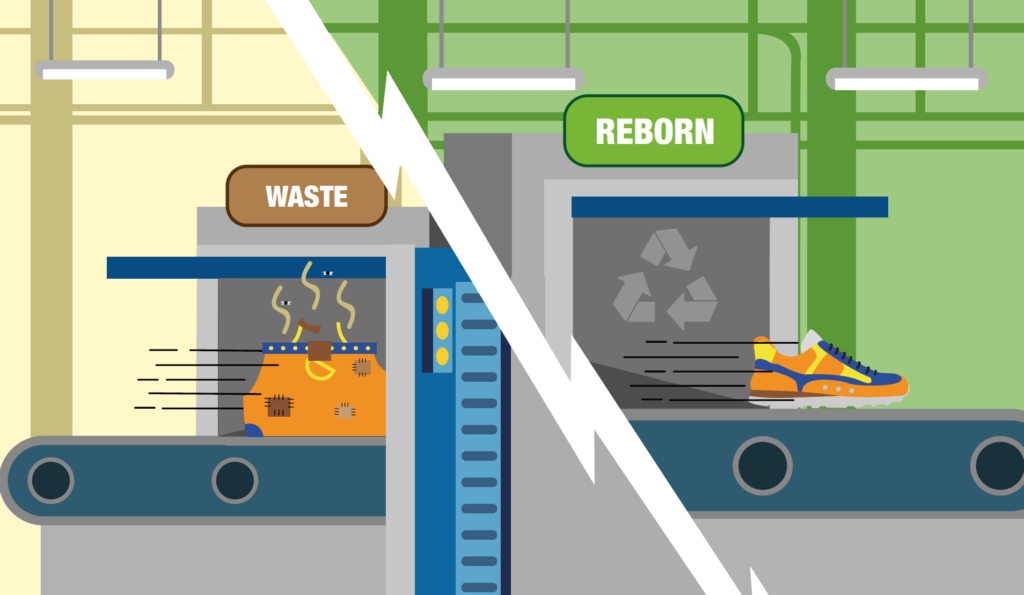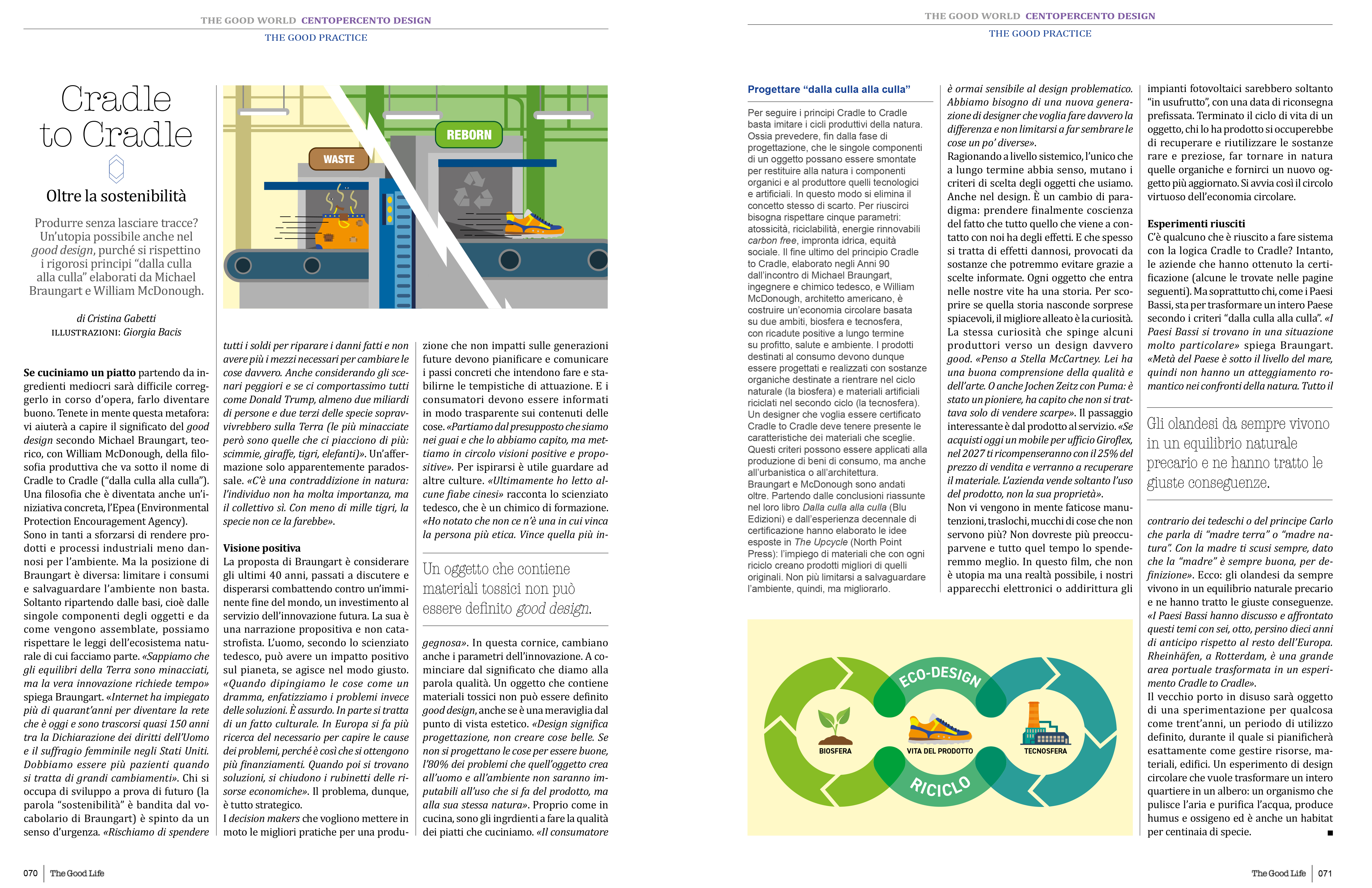Parte I
Cristina: Siamo alla Mycotheca di Torino che fa parte del Dipartimento di Scienza della Vita e Biologia dei Sistemi per raccontarvi quanto sono potenti ed efficaci i funghi. State lavorando ad un importante progetto con l’Unione Europea, ce lo racconta?
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: Certo, si tratta del progetto Life Biorest, volto alla depurazione di siti contaminati. La contaminazione del suolo è un problema enorme a livello mondiale ed europeo. Per darvi un numero, in Europa ci sono più di 200.000 siti contaminati, meno del 20% in questo momento sono diciamo trattati. Il progetto si svolge nel comune di Fidenza, è uno dei cosiddetti SIN, quindi i siti più contaminati in Italia. Abbiamo selezionato una serie di microrganismi, nel nostro caso funghi, per la loro spiccata capacità di degradare inquinanti.
Cristina: Come funziona questa depurazione?
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: Questo funghi li abbiamo isolati, fatti crescere dandogli da mangiare esclusivamente i contaminanti di questo suolo come ad esempio il pirene, il naftalene e fenantrene, poi abbiamo dimostrato come questi funghi si sono così adattati all’ambiente contaminato che preferiscono mangiare questo tipo di inquinante piuttosto che molecole come il glucosio. Li abbiamo selezionati poi per la capacità di poter crescere su substrato a basso costo, perché uno dei problemi più importanti è di far vivere e vegetare i microrganismi nel suolo. Quindi i microrganismi selezionati per le loro capacità degradative vengono poi miscelati al suolo e attraverso un sistema di questo genere vengono poi creati dei grossi cumuli di circa 1 tonnellata di suolo che viene mantenuto in condizioni controllate di temperature e umidità per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi. L’utilizzo di questo microrganismi permette di degradare una quantità molto maggiore di inquinanti e di abbreviare i tempi di trattamento, riducendo quindi anche i costi del trattamento stesso.
Cristina: Su questo terreno poi si potranno edificare case, si potrà vivere in modo sano?
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: Questo processo prevede anche una rivegetazione, quindi l’Università Cattolica di Piacenza sta selezionando una serie di piante che siano ben adattate a questi suoli. Nel momento in cui la popolazione vedrà che i microrganismi prima hanno degradato la maggior parte degli inquinanti e che le piante si accrescono su questo suolo, avrà la percezione visiva che il sito è stato veramente pulito in modo definitivo. L’area è molto vasta, di circa 18 ettari, e a causa dei bombardamenti che ci furono durante la seconda guerra mondiale gli inquinanti si spingono fino a 28 metri di profondità, quindi un volume di suolo da trattare veramente enorme.
Cristina: Quando decreterete i primi risultati?
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: I risultati che abbiamo ottenuto fino ad adesso nelle prove preliminari sono assolutamente positivi.
Parte 2
Cristina: Siamo tornati alla Mycotheca di Torino perché qui c’è la più importante collezione di ceppi di funghi d’Italia. Stanno lavorando a tantissime applicazioni, veramente strategiche per il nostro futuro, ma la cosa più interessante ancora è che di questo regno, perché così sono classificati i funghi, si conosce solo il 10%. Quali altre virtù ci vuole raccontare su questa importante popolazione di organismi?
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: I funghi, oltre che essere bellissimi sono bravissimi e li stiamo utilizzando per studiare la degradazione di tantissimi contaminanti. Un esempio molto recente è la degradazione delle materie plastiche, ci sono tanti tipi di materie plastiche anche le cosiddette bioplastiche quelle biodegradabili in realtà non sono completamente biodegradabili, la normativa si sta evolvendo nel tempo ma diciamo che ad oggi una plastica per essere biodegradabile deve avere il 40% di materiale biodegradabile che diventerà il 50% il prossimo anno il 60% nel 2020. Questo vuol dire che noi dobbiamo favorire questa degradazione, selezionando dei microrganismi in grado di degradare proprio queste materie plastiche e quindi di favorire il loro utilizzo anche in processi come quelli del compostaggio. Stiamo lavorando anche sulle microplastiche in mare, ci sono dei progetti europei per isolare ed identificare microrganismi associati a questo ambiente acquatico ed anche in questo caso per identificare i microrganismi e gli enzimi coinvolti in questa degradazione.
Cristina: Poi c’è anche tutta una classe di sostanze chimiche che non sono proprio favorevoli per la nostra salute di cui vi state occupando.
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: Si in effetti per rimanere nell’ambito acquatico, in questo momento si parla tanto dei cosiddetti interferenti endocrini, sono migliaia da molecole presenti a bassissime concentrazioni nelle nostre acqua. Parliamo di microrganismi a nanogrammi che possono avere degli impatti sulla salute delle persone. Facendo un esempio, lo sviluppo sessuale precoce nei bambini oppure l’obesità infantile. Ovviamente sono ancora cose che devono essere dimostrate in modo certo in campo medico ma insomma il pensiero comune è che quelle molecole presenti nell’ambiente abbiano un ruolo non indifferente. I funghi sono bravissimi nel degradare queste sostanze e quindi a ridurre la tossicità dei reflui civili e dei reflui industriali.
Cristina: Alcuni sono molto promettenti anche in ambito farmaceutico e di cosmetica.
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: Assolutamente si, i funghi producono milioni di metaboliti secondari che hanno attività farmacologiche e quindi ad esempio stiamo studiando le possibilità di coltivare alcuni funghi per produrre nuove molecole ad attività antibatterica, antivirale o con attività antitumorale. In particolare i funghi e, se vogliamo, i funghi provenienti dagli ambienti marini sono in questo momento tra gli organismi più studiati al mondo per la produzione di queste molecole.
Cristina: E poi concludiamo con il piacere di mangiarli. Non ci sono solo i porcini ma..
Prof.ssa Giovanna Cristina Varese: Probabilmente i funghi sono il cibo del futuro attraverso la produzione delle cosiddette micoproteine. Cibo ideale per eccellenza, ricco di proteine, con poche calorie, ricco di fibre e privo di colesterolo.
Cristina: Un universo da scoprire. Occhio al futuro.
In onda 16 e 23-2-2019